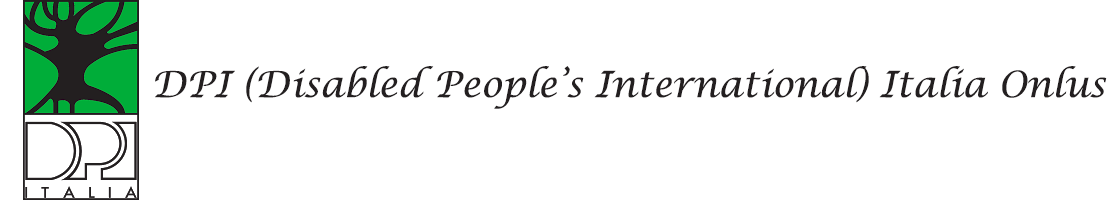le parole sono pietre
di Giampiero Griffo*
La lingua italiana aggiorna continuamente il proprio vocabolario: la conferma è data anche dalle nuove edizioni dei dizionari che introducono i neologismi: parole che descrivono nuovi fenomeni o che cercano di modificare precedenti definizione. Il recente vocabolario della lingua italiana Zingarelli ha introdotto ad esempio il termine “diversabile” (p. 579). «La Repubblica» ha commentato: «Muta anche il politicamente corretto: disabile ora si può dire diversabile»
La lingua, al contrario di quello che si pensa, è molto influenzata da quello che avviene nella società in cui è parlata. Quella degli Inut della Groenlandia, ad esempio, ha più di cinquanta maniere differenti di descrivere la neve, perché la neve è parte essenziale del loro habitat di vita.
In altri casi, quando si tratta di definire realtà nuove, nel giro di pochi anni si modifica continuamente la terminologia, producendo a volte un effetto di confusione. Quando poi si tratta di definire caratteristiche umane che, per trattamenti di discriminazioni e di esclusione, risultano “scomode” o “imbarazzanti”, allora il coacervo di parole che si accumulano sembra il deposito di un rigattiere o peggio ancora un museo degli orrori!
Spesso il mondo delle persone con disabilità è visto come un tutt’uno nel quale si presuppone una compattezza interna, che di fatto non esiste, venendo così a mancare la capacità di tenere conto delle specifiche esigenze e della valorizzazione delle risorse di ognuno. Sappiamo invece che si tratta di un mondo composto da gruppi di persone con caratteristiche molto lontane fra di loro, che non necessariamente si conoscono e sono in grado di comprendere i rispettivi problemi specifici. Pensare quindi di descrivere le caratteristiche delle persone con un’unica parola è la forma migliore per cancellarne l’esistenza concreta.
Ciò emerge in modo evidente nell’uso delle parole. Da un lato, i termini usati per definire gruppi di persone con caratteristiche diverse dalle nostre, dall’altro quelli utili a definire le persone che fanno parte del proprio gruppo.
È attiva da anni la discussione, a livello internazionale, che analizza i temi delladiscriminazione, della segregazione fisica, della mancanza di pari opportunità che le persone con disabilità subiscono dalla società. Cercare di fare il punto della situazione può aiutarci a comprendere meglio il perché la parola diversabile mi sembra assolutamente senza senso, anzi foriera di conseguenze negative per le stesse persone con disabilità.
Spesso dimentichiamo che alcune parole descrivono persone. Le immagini culturali che vengono utilizzate per descrivere le persone che hanno caratteristiche ritenute socialmente indesiderabili mettono in evidenza elementi che sono diventati senso comune: in un certo senso sono i cosiddetti “miti”, cioè quelle percezioni immaginative che non hanno bisogno di essere spiegate perché sono immediatamente evidenti e socialmente accettate.
Quando poi le persone vengono ridotte agli aggettivi che descrivono alcune loro caratteristiche, il processo di cancellazione di esse giunge al culmine.
Oggi a livello internazionale si preferisce parlare di persone con disabilità, usando il termine persona al posto delle forme aggettivali come invalido, disabile ecc., una scelta che ha il vantaggio di non attribuire all’intera persona un attributo che è solo una parte di essa e che lascia intatto un termine (persona) in sé neutro, in quanto non ha caratteristiche né positive né negative.
Un secondo aspetto da considerare è quello percettivo: tutte le terminologie usate comunemente per descrivere le persone con disabilità sono centrate su un aspetto percepito (la sofferenza, la malattia, lo svantaggio, la patologia: tutti elementi che descrivono una persona in negativo). Oppure attribuiscono caratteristiche limitate a una persona che, in più, viene gravata di una “semantica sociale” negativa.
Il combinato di queste soluzioni linguistiche è terribile: pensiamo per esempio a distrofico inabile o invalido incollocabile. Per questo, ad esempio, al termine sofferente psichiatrico, che ogni tanto si sente usare, il movimento delle persone che sono uscite indenni da un trattamento psichiatrico preferisce quello di sopravvivente psichiatrico, a sottolineare che la persona è sopravvissuta ad un’esperienza manicomiale o ad un momento di acuzie che, in ogni caso, in passato la etichettava per sempre.
Esiste poi l’espressione: persona che non può rappresentarsi da sola, definizione, questa, che nasce dallo sforzo di superare termini medici quali ritardo mentale,difficoltà di apprendimento, disabilità mentale. Lo sforzo ha lo scopo di sostituire la descrizione patologica e globale della definizione, concentrandosi sulle competenze della persona.
Si tratta certamente di una definizione di impatto, ma che è anch’essa in evoluzione. Pure in questo caso, infatti, conviene riflettere sulla legislazione, che oggigiorno prevede la possibilità di differenziare le diverse situazioni.
Un tempo l’impossibilità di rappresentarsi, dal punto di vista legale, era irreversibile e riguardava l’insieme della persona (l’istituto giuridico dell’interdizione); oggi la nuova Legge sull’Amministratore di Sostegno (Legge 6/2004) ha introdotto il concetto di interdizione parziale e reversibile.
Finalmente è possibile quindi rivedere dei giudizi che un tempo, una volta emessi, erano di condanna permanente all’esclusione sociale.
Certo, possiamo immaginare che una persona che non sa gestire il denaro possa non arrivare a gestirlo mai, ma per quanto riguarda le scelte relative a come preferisce vivere – scegliere un gelato alla fragola o alla nocciola per esempio – egli è perfettamente in grado di valutarle, prenderle ed esprimerle.
Certamente è possibile agire bene e parlare male, in quanto i linguaggi si cristallizzano, anche se così spesso il parlare male è l’indizio di una certa superficialità e carenza di riflessione. Non bisogna però dimenticare che le espressioni corrette sono tali non solo perché “politicamente corrette”, ma anche perché non feriscono chi le riceve.
È vero che in fondo il linguaggio serve a farsi capire, ma quando si tratta di descrivere le caratteristiche delle persone non si tratta più solo di una descrizione, ma della proiezione di una visione sociale di quelle caratteristiche.
Perciò nel caso delle persone con disabilità, non si può prescindere dalla storia che ha prodotto quella visione sociale negativa. Qui infatti la parola trasmette anche la visione che la società ha delle persone che hanno determinate caratteristiche. Nel nominalismo medievale si riteneva che i nomi fossero talmente appropriati da essere in sé l’oggetto. Vi è un fondo di verità in questa apparente esagerazione.
Il significato di una descrizione che la parola mette in evidenza ha un’oggettività percettivaparagonabile a quella delle pietre, la descrizione che viene veicolata ha un peso specifico anche molto pesante.
Spesso si percepisce il linguaggio (nel suo significato di descrizione di qualcosa e di percezione che quella parola genera in chi la ascolta) come la rappresentazione dell’ovvietà, dimenticando che i linguaggi sono frutto di una storia: la storia delle persone con disabilità è storia di segregazione, esclusione, cancellazione sociale e le parole che identificano queste persone sono state scelte da altri, pensate attraverso un approccio culturale con la diversità che ha privilegiato la scelta di proiettare fuori da se stessi gli aspetti che la società (e le persone di quella società) riteneva negativi e socialmente indesiderabili.
Questo processo in termini linguistici ha prodotto il trasferimento di una valutazione, negativa su determinate persone. Di fatto ognuno di noi può, a un determinato punto della vita e per i motivi più diversi, vivere un’esperienza di follia: Franco Basaglia ha messo in evidenza che ognuno ha dentro di sé questa possibilità e, semplicemente, chi è in manicomio non è sopravvissuto a questa evenienza senza essere ricoverato.
Basaglia usava una frase che descrive bene l’unicità di ogni persona: «visto da vicino nessuno è normale». Dobbiamo essere consapevoli di questo e ricordare sempre che le parole sono come pietre e vanno usate con molta attenzione.
Naturalmente i termini che descrivono le persone con disabilità sono in evoluzione continua, proprio perché il movimento di emancipazione mondiale conquista ogni giorno di più forza e coscienza della propria condizione.
Esaminando la legislazione italiana si vede chiaramente il processo che ha portato da termini come invalidi o inabili, in un mondo in cui esistevano le classi speciali e gli istituti, ai termini di handicappati o portatori di handicap, diventati comuni con la Legge quadro sull’handicap 104/92, che agiva in una società che rivendicava l’integrazione sociale, sottolineando lo svantaggio sociale che la società stessa produceva.
Vi era ancora in quella descrizione un’attribuzione negativa alla persona che soggettivamente veniva gravata di una negatività.
Il passo successivo ha portato alla definizione di persone con disabilità, quella attualmente riconosciuta e accettata dal movimento internazionale, in cui al concetto di persona – universalmente accettato e ritenuto positivo – si accomuna un’attribuzione ricevuta: quel“con”, infatti, descrive qualcosa che non appartiene a quella persona, ma gli è imposto.
Infine, il concetto di disabilità è mutuato dalla recente definizione dell’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): la disabilità è prodotta dal rapporto tra le caratteristiche delle persone e l’ambiente in cui esse vivono e le capacità che le persone stesse hanno sviluppato.
Muovendomi in sedia a rotelle, ho una disabilità quando il luogo in cui mi muovo ha dislivelli in verticale superabili solo con scale o quando – orientandomi con un bastone bianco – non vi sono pavimentazioni o guide sonore che consentano di spostarmi in sicurezza. In ambedue i casi, la disabilità non è un fattore soggettivo (dovuto a cecità o paralisi agli arti inferiori della persona), bensì è causato da una società che non ha progettato per tutti.
Lo stesso vale per le capacità soggettive, che se sono rafforzate e potenziate consentono di superare altri ostacoli e barriere: pensiamo al conseguimento della patente di guida per una persona che vive in una città con autobus inaccessibili o a una persona che non è in grado di svolgere compiti complessi a cui viene offerto un lavoro con mansioni semplici e ripetitive.
La disabilità dipende quindi dall’invisibilità sociale e politica (delle persone con disabilità si occupano solo la sanità e l’assistenza) che cancella spesso le responsabilità ad agire di chi si occupa di trasporti, di turismo, di lavoro, di tempo libero. E nello stesso tempo dipende dall’impoverimento sociale cui le persone con disabilità sono state sottoposte: chiuse in famiglia, in istituto, in classi speciali, esse sono state letteralmente impoverite di competenze sociali.
Oggi, il nuovo approccio dell’ICF ha quasi eliminato anche un’altra negatività che veniva attribuita a chi conviveva con una disabilità: la medicalizzazione (il concetto di menomazione come elemento che produce l’handicap). Nell’ICF, infatti, si parla di strutture e attività, termini più generici che appartengono a tutti, talché la disabilità è una condizione ordinaria della vita che appartiene a tutto il genere umano nell’arco della propria esistenza e non è legata ad una condizione di malattia.
Purtroppo ancor oggi per poter beneficiare di determinati diritti e provvidenze si usano definizioni medicalizzanti o negative, utilizzate negli accertamenti diagnostici, che portano all’uso di linguaggi descrittori sanitari (certificati medici, scolastici ecc.). Questo linguaggio confonde purtroppo la soglia oltre la quale poter godere di un beneficio o di una provvidenza, con la pretesa di descrivere la persona. Bisogna quindi costruire un linguaggio che faccia capire come le persone sianoun insieme di caratteristiche e che questo insieme compone una persona che non può essere ridotta ad una di queste caratteristiche (spesso solo quelle considerate negative).
Cosa ci propone invece l’inaccettabile diversabili?
Innanzitutto riduce una persona ad un suo eventuale attributo, cancellandone le specificità. In secondo luogo, l’attributo che viene scelto per definire la persona appartiene a tutte le persone: conoscete persone che possano essere definite “ugualabili”? Cioè le cui capacità e abilità siano uguali a quelle della persona che gli sta a fianco sul tram? E ancora, è più diversabile la persona che non sa guidare un’auto da quella che guida con i comandi a mano? Ha più diverse abilità l’analfabeta rispetto al non vedente che legge con la sintesi vocale?
Il termine infine produce un ulteriore elemento negativo: cercando di definire – secondo chi lo utilizza – in maniera positiva le capacità delle persone, cancella la condizione di discriminazione e di mancanza di pari opportunità che queste stesse persone subiscono dalla società e dai processi di impoverimento.
Non è un caso che negli ultimi anni questa definizione assolutamente inappropriata venga a nascondere un abbassamento dell’impegno delle istituzioni e della società nel suo complesso: «se sono diversabili – ci dice questa parte della società – allora non ho più nulla da fare, se la risolveranno con le loro forze…».
Viene così di nuovo relegata nel privato la soluzione degli “eventuali” problemi.
Vorrei concludere il mio intervento ricordando quello che sottolineavo prima: le categorializzazioni astratte producono classificazioni semplificatorie e processi di invisibilità sociale.
Non è un caso che la FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) rivendichi la personalizzazione degli interventi, i progetti individuali, gli interventi che partono dalle violazioni di diritti umani che le persone con disabilità e le loro famiglie vivono ogni giorno.
Il bisogno deve arrivare ad essere così chiaramente espresso da far emergere quella sorta di normalità che appartiene a ciascuno. Personalizzando si scopre che tutte le persone vogliono vivere una migliore qualità della vita e hanno bisogno di determinati servizi per conseguirla: non si attribuisce più niente di negativo alle persone, si prende atto di necessità, bisogni, desideri.
Questo semplice approccio richiede una maggiore attenzione alla condizione delle persone svantaggiate, ma a ben riflettere è appropriato per tutte le persone.
Certamente è vero che le persone con disabilità fanno alcune cose in modo differente, ma la differenza non ci fa diversamente abili: chi usa da anni una carrozzina non la usa in modo diverso da chi cammina con le proprie gambe, semplicemente la usa, mentre l’altra persona non ci si è neanche mai seduta sopra.
La dura realtà è che è ancora lunga la strada per far accettare le diversità umane come ricchezza: il colore della pelle, le credenze religiose, l’orientamento sessuale, l’età, la condizione di disabilità sono ancora considerate caratteristiche socialmente indesiderabili. E sono solo queste diversità che producono lo stigma sociale negativo che la società ci attribuisce, per cancellare il trattamento diseguale e discriminatorio che ha riservato alle persone che avevano quelle caratteristiche. Ricondurre ad ordinarietà tutte le caratteristiche umane è l’obiettivo di un linguaggio rispettoso e inclusivo.
Il movimento mondiale delle persone con disabilità è stato capace di usare nuovi linguaggi e nuove forme di descrivere il mondo che non esclude: universal design, empowerment,mainstreaming sembrano parole lontane, ma diventeranno presto reali quando laConvenzione dell’ONU per la Tutela della Dignità e i Diritti delle Persone con Disabilità darà un’altra spallata all’imbarazzo di chi pretende di descriverci con le sue parole.
10 ottobre 2005
Pubblicato sul sito: www.superando.it